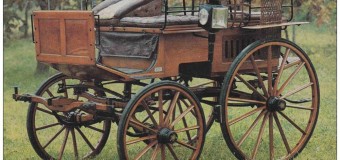A Salcedo (VI), piccolo paese della pedemontana vicentina, in via Roma 5, si trova un’interessante collezione privata dedicata alla bicicletta. Questo museo è stato realizzato con pazienza, dedizione e grande competenza da Loris Pasquale, nato a Vicenza nel 1962, che fin da bambino fu affascinato dal collezionismo di vario tipo: figurine di calciatori, monete, francobolli, farfalle, minerali, fossili e altro.
Aveva vent’anni quando un amico di famiglia, un meccanico di biciclette di Breganze (VI), regalò a suo padre Francesco una vecchia bicicletta equipaggiata con motore a rullo, modello Mosquito 38. Loris fu subito affascinato da questo veicolo a due ruote che fece scattare in lui la passione di cercare e collezionare altri modelli di biciclette. In pochi anni la sua collezione di biciclette e accessori è cosi cresciuta fino a dar vita ad un vero museo visitabile dal pubblico.
Nella suggestiva esposizione figurano centinaia di biciclette storiche a partire dal biciclo Michaux datato 1861 (con pedali e sella regolabili) fino ai modelli dei nostri giorni, insieme ad accessori di vario tipo tutti relativi alla bicicletta e alla sua storia, quali magliette, vestiti d’epoca, riviste, cartelloni pubblicitari, manifesti, libri, cataloghi, medaglie, fanali.
Notevoli e numerosi i mezzi a pedali dell’Ottocento, fra i quali Howe del 1870,Turri del 1887, Singer del 1880, Rudge del 1878, il triciclo Peugeot del 1894 dotato di differenziale, la Metropole del 1898 con trasmissione e cardano, Non mancano pregevoli esemplari del Novecento, i più antichi la Dursley Pedersen del 1903, la Sunbeam Two Speed del 1904, la Labor del 1905, la monoforcella Lefty che ha ispirato alcune moderne mountain-bike e la Terrot del 1907.
Molto rara la Levocyclette del 1905 a pedalata alternata, non circolare, grazie ad una tecnologia raffinata. Altrettanto pregiate la Magnat Debon del 1901 con cambi differenti e pedalata nei due sensi, avanti e indietro. Nella Flora del 1915 la canna si abbassa e la bici si trasforma in mezzo da uomo in bici da donna. Geniale la Humber Cycle del 1904 che veniva proposta in scatola di montaggio, come pezzi di ricambio, per sfuggire alle regole del dazio. Nella Hirondelle del 1915 -dotata di retropedalage– pedalando in avanti si affrontava la strada in pianura e all’indietro quella in salita. Curiose le “Ciclopalla”, specialità sportiva che permette di giocare al calcio in bicicletta. La palla, ad eccezione del portiere quando si trova all’interno della propria area di rigore, può essere giocata toccandola solamente con le ruote della bicicletta. Le squadre, a seconda della variante del gioco considerata, sono normalmente composte da due, cinque o sei giocatori per parte. L’invenzione del gioco della ciclopalla viene attribuita al ciclista statunitense, di origini tedesche, Nick Kaufmann. Kaufmann avrebbe avuto l’ispirazione imbattendosi in un cane di piccola taglia mentre era alla guida della bicicletta, scansandolo delicatamente a lato della strada con la ruota anteriore. Kaufmann ebbe così l’idea di sostituire il cane con una palla, dando vita nel 1893 a Rochester -sua città natia negli Stati Uniti- alla prima partita di ciclopalla. Molto ammirato anche il tandem con sedute parallele di Dei, che permetteva ai due ciclisti di conversare, viaggiando uno accanto all’atro e non uno dieto l’altro. Solo uno però guidava il mezzo con il manubrio. Il secondo manubrio era d’appoggio.