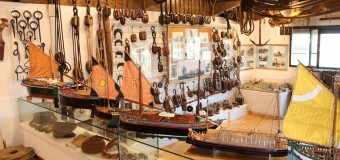Nel dicembre del 2015 l’ASDPJ 4X Racing Team, presieduto da Paolo Marozzo, inaugurava il primo Museo Storico Kawasaki WMX (Vintage Motocross), con il patrocinio del Comune di Castrolibero, del C.O.N.I. e della Regione Calabria, con il riconoscimento ufficiale dell’importatore Kawasaki Italia e dell’AHRMA (American Historic Motorcycle Association). Il MIBACT, Direzione Generale Musei, avrebbe contribuito a sua volta alla creazione del sito web del Museo www.kawasakivmxmuseum.it e alla realizzazione del museo virtuale, nell’ambito del Progetto di Digitalizzazione dei Musei (D.M. n.451/2020 e D.M. n.62/2021). Dopo una intensa e positiva fase gestazionale che, negli ultimi anni, ha portato al traguardo delle 10.000 presenze annuali grazie anche alle attività collaterali come gli open day, le tavole rotonde con gli studenti, le mostre d’arte e fotografiche tematiche, e agli incontri con campioni del motociclismo (la più emozionante è stata quella con il grande Alessandro “Ciro” De Petri) il Museo si è trasferito nella nuova prestigiosa sede a Camigliatello Silano, celebre località sciistica in Calabria, del Comune di Spezzano della Sila (CS). Un Museo innovativo ed altamente tecnologico progettato per accogliere visitatori da tutto il mondo ed incentivare i flussi turistici nella regione. La nuova struttura museale ha una superficie complessiva di 1500 Mq distribuita su tre livelli di 500 Mq ciascuno che includono: un settore dedicato a Steve Mc Queen, alla sua Kawasaki originale del 1970 ed alla sua cinematografia, un settore dedicato alla Biblioteca dello Sport (in collaborazione con il CONI e intitolata alla memoria del celebre giornalista fotografo del Mondiale di Motocross “Adriano Dondi”, un settore, quello principale, dedicato alla esposizione “Statica e Multimediale” dei modelli Kawasaki che hanno fatto la storia del motocross internazionale. L’attuale collezione, dall’inestimabile valore e divenuta di proprietà della Fondazione Kawasaki VMX Museum Italy, comprende attualmente 15 esemplari prototipi originali (No Repliche) della serie SR che hanno gareggiato in tutto il mondo. Si tratta della Kawasaki F81M 250 (1970), uno dei sei esemplari Kawasaki che la casa giapponese aveva dato in promozione a Steve Mc Queen durante la realizzazione del film Le Mans ed appartenuto successivamente alla collezione privata dell’attore Burt Reynolds; delle Kawasaki KX 450 F12 (1974) della Kawasaki KX 250 A5 (1979) della Kawasaki 500 SR (1980) di Brad Lackey, primo ed unico americano a vincere il Campionato Mondiale Motocross nella categoria 500cc nel 1982; delle Kawasaki KX 250 A1 (1974) e Kawasaki KX 250 A2 (1975) guidate a scopo promozionale per Kawasaki USA da Ryan Villopoto, pilota americano attivo tra il 2006 e il 2014 e vincitore di ben 83 competizioni nelle categorie 250cc e 450cc dell’ American Motorcyclist Association (AMA); della Kawasaki KX 400 A2 (1976) donata dall’associazione americana Raccolta Fondi Reduci Vietnam; della Kawasaki KX 250 A4 (1978), dell’americano Gary Semics; della Kawasaki KX 250 A7 (1981) di David Bailey, pilota americano con all’attivo 30 vittorie nei campionati dell’AMA e campione nella 250cc e 250CX cc nel 1983 e nella 500cc nel 1986 e 1987; della Kawasaki KX 250 B1 Prototype SR (1982) Kawasaki Japan; della Kawasaki KX 250 C1 SR (1983) di Billy Liles pilota americano attivo nelle competizioni del Mondiale Motocross tra il 1982 e il 1994; della Kawasaki KX 500 B2 (1986), USA version, pilotata in alcune gare di Supercross americano da Georges Jobè, vincitore di cinque titoli mondiali motocross nella 250cc (1980 e 1981) e nella 500cc (1987, 1991 e 1992); della Kawasaki KX 500 C1 (1987), destinata alla guida del pilota italiano Eno Carducci del Kawasaki-Cinti Team, partecipante al Motocross World Championship nel 1986 e 1987; la Kawasaki KX 250 F1 (1988) di Larry Brooks, pilota americano dalla lunga carriera alla guida di varie case motociclistiche ed, infine, la Kawasaki KX 60 B15 1999 con cui iniziò a correre Jorge Lorenzo, pilota spagnolo con all’attivo ben cinque titoli nel moto GP. Entro l’anno la collezione verrà arricchita con altri sei prestigiosi esemplari di provenienza Kawasaki USA appartenuti a piloti iconici del Supercross tra cui Jeff Ward e Ron Lechien e tutti da 500 cc.
Giorni di apertura: Venerdi – Sabato – Domenica
Orari: dalle 10,00 alle 20,00